La Sicilia nella Storia de’
“Il Gattopardo”
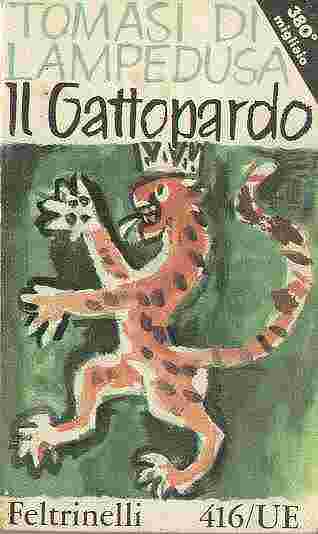 In uno alle tematiche delle varie epoche, ai testi allegorici, al documentarismo storico-sociale, la narrativa italiana del ‘900 ha dato particolare rilevanza, più o meno obiettivamente e realisticamente, alle problematiche socio ambientali delle regioni del Sud e particolarmente della Sicilia. Ciò perché il Sud ha rappresentato da sempre, e forse lo rappresenta tuttora, un mondo a se. Portatore d’antichissima storia e cultura, di radicate tradizioni, ricchissimo d’impareggiabili paesaggi e d’insigni monumenti, è stato nei secoli oppresso e sfruttato, trascurato e dimenticato, talvolta con la connivenza di ben noti esponenti della classe nobiliare e politica, oltre che di una parte della gerarchia ecclesiastica. Le inadeguate iniziative adottate nel corso del pur deprecato “ventennio”, tendenti ad attutire le conseguenze delle ben note colpevolezze di matrice borbonica e, ancor più, dei governi succedutisi dopo il l’unificazione della penisola sotto Casa Savoia (1870), furono solo dei palliativi e non rappresentarono affatto una svolta. Il “problema meridionale”, anche nell’ambito del nuovo quadro istituzionale e politico del secondo dopoguerra (1946), si ripropose in tutta la sua gravità. In Sicilia, in particolare, ci si trovò di fronte al riaffiorare di sussulti separatisti mentre ci si dovette rendere conto che le già scarse fonti di ricchezza s’erano vieppiù concentrate nelle mani di una ristretta cerchia di operatori che badavano, in quanto privi di interessi sociali, solo ai propri profitti. In molti casi, addirittura, ci si trovò al cospetto di speculatori arricchitisi con raggiri, con sistemi da “borsa nera” e con l’usura. Il “latifondo”, per altro verso, era divenuto la palla al piede delle moribonde classi nobili e patriarcali. Una nuova e massiccia emigrazione fu la conseguenza di tale stato di cose ed ebbe l’effetto di depauperare la forza lavorativa che faceva capo alle classi medio basse. In tutta la sua ampiezza e gravità emerse una situazione precaria ed esplosiva che, in relazione ai fattori storico politici da cui traeva origine l’evidente arretratezza del Meridione e a fronte della tangibile miseria che affliggeva la gran massa della popolazione, stava determinando un clima di violenza e di scontri sociali in cui il “conservatorismo” recitava la parte del mandante e la “sinistra” tentava di stare al passo con finalità financo rivoluzionarie. La tanto strombazzata solidarietà nazionale, anche questa volta, perse l’occasione di agire in maniera risolutiva, malgrado fosse stata evidenziata, da più parti, la necessità di intervenire al più presto con speciali e concreti provvedimenti sociali e strutturali. In uno alle tematiche delle varie epoche, ai testi allegorici, al documentarismo storico-sociale, la narrativa italiana del ‘900 ha dato particolare rilevanza, più o meno obiettivamente e realisticamente, alle problematiche socio ambientali delle regioni del Sud e particolarmente della Sicilia. Ciò perché il Sud ha rappresentato da sempre, e forse lo rappresenta tuttora, un mondo a se. Portatore d’antichissima storia e cultura, di radicate tradizioni, ricchissimo d’impareggiabili paesaggi e d’insigni monumenti, è stato nei secoli oppresso e sfruttato, trascurato e dimenticato, talvolta con la connivenza di ben noti esponenti della classe nobiliare e politica, oltre che di una parte della gerarchia ecclesiastica. Le inadeguate iniziative adottate nel corso del pur deprecato “ventennio”, tendenti ad attutire le conseguenze delle ben note colpevolezze di matrice borbonica e, ancor più, dei governi succedutisi dopo il l’unificazione della penisola sotto Casa Savoia (1870), furono solo dei palliativi e non rappresentarono affatto una svolta. Il “problema meridionale”, anche nell’ambito del nuovo quadro istituzionale e politico del secondo dopoguerra (1946), si ripropose in tutta la sua gravità. In Sicilia, in particolare, ci si trovò di fronte al riaffiorare di sussulti separatisti mentre ci si dovette rendere conto che le già scarse fonti di ricchezza s’erano vieppiù concentrate nelle mani di una ristretta cerchia di operatori che badavano, in quanto privi di interessi sociali, solo ai propri profitti. In molti casi, addirittura, ci si trovò al cospetto di speculatori arricchitisi con raggiri, con sistemi da “borsa nera” e con l’usura. Il “latifondo”, per altro verso, era divenuto la palla al piede delle moribonde classi nobili e patriarcali. Una nuova e massiccia emigrazione fu la conseguenza di tale stato di cose ed ebbe l’effetto di depauperare la forza lavorativa che faceva capo alle classi medio basse. In tutta la sua ampiezza e gravità emerse una situazione precaria ed esplosiva che, in relazione ai fattori storico politici da cui traeva origine l’evidente arretratezza del Meridione e a fronte della tangibile miseria che affliggeva la gran massa della popolazione, stava determinando un clima di violenza e di scontri sociali in cui il “conservatorismo” recitava la parte del mandante e la “sinistra” tentava di stare al passo con finalità financo rivoluzionarie. La tanto strombazzata solidarietà nazionale, anche questa volta, perse l’occasione di agire in maniera risolutiva, malgrado fosse stata evidenziata, da più parti, la necessità di intervenire al più presto con speciali e concreti provvedimenti sociali e strutturali.
E’ ampiamente dimostrato che, dopo la sceneggiata dell’annessione della Sicilia al nascente Regno d’Italia, i governanti sabaudi ben poco fecero, di sostanziale, per venire incontro alle necessità della vessata popolazione isolana e per colmare il divario economico, sociale e strutturale esistente nei confronti di molte altre regioni del nuovo Stato. Amareggia parecchio, a tal proposito, la riflessione che fra la classe dirigente dell’epoca siano da annoverare parecchi siciliani: Francesco Crispi, Vittorio Emanuele Orlando, Antonino Paterno Castello Marchese di Sangiuliano, Antonio Starabba Di Rudinì, ecc., tre dei quali, Crispi, Orlando e Di Rudinì, ricopersero addirittura l’incarico di “Capo del Governo”.
Su questa linea critica, particolarmente per quanto attiene l’assenteismo delle preposte autorità pubbliche, si attestarono, nel tempo, scrittori come Alvaro, Vittorini, Brancati, cui seguirono, a fronte di una più decisa posizione politica e morale, Silone, Iovine, Levi, e Sciascia. Parecchi altri autori, parimenti, hanno manifestato e sostenuto il proprio impegno socio culturale attraverso forme di narrativa storica all’uopo utilizzata per fare emergere forti messaggi attinenti la realtà sociale e ambientale siciliana. Per molti autori il mondo della storia e della cronaca sarà poco più che un pretesto giacché appaiono maggiormente interessati alla vita della società, osservata entro i ristretti confini delle convenzioni e delle tradizioni ambientali, più che capaci di concentrarsi nello sforzo di penetrare nell’io interiore dei personaggi e nelle problematiche socio ambientali. Personaggi che spesso appaiono condizionati dalla suggestione del soprannaturale, dall’astrologia e dalle arti divinatorie, oltre che succubi di superstizioni, fanatismo e fatalismo religioso. Nel quadro epocale e interpersonale dei rapporti umani, però, sapranno descrivere bene, in genere, gli effetti della appartenenza a determinate classi sociali, delle diversità di esigenze di vita, di formazione culturale e religiosa, ecc. Coloro i quali, infine, non sono culturalmente coinvolti in impegni ideologici o politici, saranno portati a trattare temi psicologici, morali, familiari, quasi esclusivamente tallonati dalla tendenza a porre in rilievo la personalità, positiva o negativa, dell’ “uomo protagonista”, i suoi piccoli e grandi problemi, i suoi vizi palesi o occulti, i suoi modi di sentire e d’essere. I variegati risvolti della coscienza, specie quando sono parecchio incisivi, sono talvolta solo marginalmente affrontati dal punto di vista della morale collettiva, pur tenendo conto del coinvolgimento religioso che spesso è puro formalismo quando non semplice ipocrisia.
In quest’ultima fascia letteraria, sotto la dicitura di “romanzo psicologico”, si può collocare la “confessione” autobiografica e “in chiave storica” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sapientemente diluita, fra un avvenimento e un’altro, fra un’incontro e un’altro, fra un dialogo e l’altro, nelle pagine della sua opera più conosciuta, “Il Gattopardo”.
Va subito detto che Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo 1896 – Roma 1957), il cui albero genealogico affonda le radici in una delle più nobili famiglie di Sicilia, solo dopo la sua morte venne riconosciuto e apprezzato come scrittore.
Cresciuto nell’agiatezza, fra i rigidi schemi e le ataviche usanze delle classi patrizie, ebbe il vantaggio di studiare con regolarità, in un ambiente adeguato ed ebbe anche la possibilità di viaggiare a lungo. A vent’anni interrompe gli studi di giurisprudenza e, conseguito a Torino il grado di sottotenente, parte per il fronte. Fatto prigioniero dagli austriaci sull’altopiano d’Asiago, fu rinchiuso nel campo di concentramento di Pousen dal quale fuggì raggiungendo a piedi Trieste. Nel 1919, in servizio effettivo, rientra nel Regio Esercito dal quale si dimetterà poi, nel 1925, per le sue idee antifasciste, anche se non assumerà mai una vera e propria posizione di oppositore dichiarato del regime ma solo quella, come lui stesso amava dire, di “dissenziente solitario”. Viaggia per tutta l’Europa e nel 1932 sposa, in Lettonia, dopo un lungo periodo di intima frequenza, la baronessa Alessandra Wolff Stomersee. Partecipa alla seconda guerra mondiale col grado di capitano d’artiglieria. Negli anni postbellici, infine, s’inserisce a pieno titolo nell’ambiente letterario e si lega d’amicizia con molti giovani frequentatori dei “salotti culturali”, romani e palermitani. Fra tanti illustri personaggi dell’epoca, conosce Eugenio Montale e Giorgio Bassani. Proprio quest’ultimo, nel 1958, ad un anno dalla morte dell’autore, s’assumerà il compito di dare alle stampe, nella stesura definitiva del 1957, “Il Gattopardo”, romanzo che il Lampedusa aveva terminato di scrivere tra il 1955 e il 1956, ma
che, secondo la testimonianza della moglie, aveva subito, da oltre un decennio, continue rielaborazioni.
Il libro, per la prima volta pubblicato, nell’autunno del 1958, dall’editore Feltrinelli, otterrà, nel 1959, l’alto riconoscimento del “Premio Strega”.
Nel caso de “Il Gattopardo”, in ogni caso, il significativo successo, di cui ancora oggi può gloriarsi, è scaturito più dall’entusiastico e stabile consenso del pubblico, anche a livello internazionale, che dal citato riconoscimento. Ciò perché il lettore è riuscito a trovare nel romanzo argomenti soggettivamente condivisibili, raffronti con la propria vita vissuta, interessanti riferimenti epocali e generazionali, qualcosa, in definitiva, di se stesso. Il tutto in un contesto narrativo brillante e suggestivo che fa emergere sentimenti, valutazioni ideali, convinzioni, aneliti di idealismo libertario.

Nel libro si narra la vita del principe Fabrizio Corbera di Salina Lampedusa, uno dei più alti dignitari siciliani accreditati
presso la Corte borbonica di Napoli. La storia del Principe, sul cui blasone fa bella mostra di se un rampante “gattopardo”, è ambientata a Palermo e a “Donnafugata”, un paese immaginario i cui luoghi sono riferibili a Palma di Montechiaro, Comune della provincia di Agrigento di cui i Lampedusa furono fondatori oltre che per lungo tempo “signori”. In detto Comune trovasi il Convento della Beata Corbera, antenata dei Salina (l’attuale Monastero di Santo Spirito), il Palazzo del Duca Santo (rilevante costruzione barocca ancora oggi conosciuta come “palazzo dei Lampedusa”) e la Chiesa Madre “dalle tozze colonne di marmo rosso”.
La decadenza della famiglia Salina Lampedusa, in ogni caso, appare parecchio dignitosa e comprensibile, specie se paragonata al convulso rantolo del vasto e frastagliato mondo della nobiltà siciliana post medioevale. Essa appare legata, forse non casualmente, all’annunciato tramonto della monarchia dei Borboni che per oltre un secolo, dal 1735 al 1860, aveva dispoticamente governato il meridione d’Italia (Regno delle due Sicilie).
Il Principe, notoriamente d’indole pigra e fatalistica, era l’indiscusso e assoluto dominatore della famiglia ma ciò non influiva più di tanto sulla tendenza a interessarsi ben poco delle incombenze di amministratore delle sue consistenti proprietà (l’isola di Salina, nelle Eolie - da cui trae nome il casato -, i feudi di “Querceta”, “Ragattisi” e “Argivocale”, la rinomata tenuta di “Donnafugata”). In relazione, poi, alla ereditata posizione di prestigio nobiliare, si troverà ad essere, suo malgrado, vittima e complice al tempo stesso degli avvenimenti che porteranno alla caduta del Regno borbonico e all’annessione della Sicilia al Regno sardo piemontese. Il corposo romanzo “Il Gattopardo” è da molti considerato come una sorta di rivisitazione del periodo storico che vide l’inarrestabile declino del casato dei Salina Lampedusa, cui l’autore - come già detto - apparteneva per comprovato lignaggio. Il libro riporta il lettore nella situazione ambientale e politica della Sicilia del 1860, epoca che, a giudizio di molti, fa emergere straordinarie rispondenze con quella storicamente più vicina ai nostri giorni e, per molti versi anche con quella odierna, creando le motivazioni per cui, frequentemente, si fa ad essa riferimento per trarne citazioni e moniti. La storia magari
ama ripetersi ma la mentalità rimane sempre la stessa.
L’evidente parallelismo tra il sistema monarchico del reame di Napoli e quello di Casa Savoia, tra il dominio borbonico e la dittatura fascista, tra l’ignavia dei comandanti militari borbonici e quella dei generali italiani del
1939 - 1943, tra la conquista garibaldina del 1860 e l’invasione alleata del 1943, fa affiorare,
alla stregua di un continuo allusivo accostamento, reiterati riferimenti all’ottusa arroganza dei “dominatori” d’ogni tempo.

Vi si può scorgere, anche, un implicito parallelismo tra la situazione d’allora e la posizione etica e morale dei nuovi venuti della politica di oggi, nell’alternanza dei giochi di potere e nei riflessi spesso negativi o involutivi che si determinano nei rapporti fra governanti e governati. E non mancano più o meno chiari accenni alla codardia e ai comportamenti indecisi del monarca d’allora, descritto come …”un seminarista vestito da generale” che, incrinando e trascurando il rapporto di fiducia con i sudditi, mette in forse l’esistenza stessa del regno e crea prospettive politiche e sociali confuse e incerte (…“i Re che incarnano un’idea non possono e non devono scendere al di sotto di un certo livello…”). Precisa e lineare valutazione comportamentale facilmente accostabile, vedi caso, all’ingloriosa uscita di scena di un monarca nostrano di
più recente memoria.
La chiave interpretativa e di lettura è affidata, tuttavia, alla perspicacia e all’intuizione del lettore, anche perché fatti e avvenimenti esposti non esulano mai dal rigore della ricostruzione storica riferita al periodo assunto come sfondo.
Le vicende del Principe siciliano, che “signoreggia su uomini e cose” e che agisce sotto la spinta di “un carattere e di un orgoglio zeusiano”, sono legate a filo doppio con quelle degl’altri personaggi :
* il nipote Tancredi, spiantato discendente del collaterale casato dei Principi
Falconeri e del quale Don Fabrizio è tutore, che, nel lasciare il palazzo dei Lampedusa per “correre sulle montagne a rinforzare le bande dei “picciotti” - arruolandosi nelle file dei garibaldini -, rivolto all’adorato “zione” manifesta il suo pensiero affermando prima che …“se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica” e pronunciando, poi,
la famosa frase oggi d’uso comune: ….“bisogna che tutto cambi, se vogliamo che tutto resti com’è”. Per la cronaca, dopo essere stato ferito, Tancredi diventa capitano ed entra a fare parte dell’esercito “piemontese”, pur essendo quest’ultimo sostanzialmente ben lontano dall’essere un esercito …”italiano” ;
* il possidente Calogero Sedara, un grezzo personaggio ex contadino che, arricchitosi a dismisura in funzione dell’innata mancanza di scrupoli verso il prossimo, coglie al volo l’occasione del cambiamento di regime per farsi nominare sindaco di Donnafugata ;
* la figlia di quest’ultimo, Angelica (“bella fra le belle”) che ha accettato con entusiasmo la corte e la dichiarazione d’amore di Tancredi, permettendo al padre contadino di realizzare il progetto di entrare a fare parte della società nobiliare dopo avere assicurato, in cambio, il riassetto delle finanze del genero;
* la moglie del Principe, Maria Stella, la cui immagine di donna sottomessa all’autorità del marito è ben definita, anche sul piano psicologico, così come quella delle figlie;
* il Padre gesuita, Don Pirrone, che segue il Principe nelle sue osservazioni astronomiche e che, senza mai venire meno alla dovuta deferenza, dialoga con lui d’ogni argomento familiare, sociale e politico.
* altri incisivi personaggi sono l’integerrimo contabile don Ciccio Ferrara, il “sovrastante” Pietro Russo - influente caporione mafioso che ha molta voce in capitolo in quel di Girgenti -, l’amico di Tancredi, il milanese Conte Cavriaghi - diciannovenne “ufficialetto” che s’innamora di Concetta, figlia del Principe e figlioccia del Re delle Due Sicilie -, don Onofrio Rotolo - l’amministratore di Donnafugata che il Principe stima molto perché “è, forse, la sola persona che non l’avesse mai derubato” -.
Tutti costoro adempiono, più che altro, alla funzione di porre maggiormente in risalto la carismatica figura del Principe e di contribuire a creare l’atmosfera dei luoghi e dell’epoca. Personaggi che, felicemente scolpiti dalla penna dell’autore, appaiono e scompaiono fra le quinte delle vicende che si susseguono e si sovrappongono.
Altrettanto ben tratteggiata è la descrizione dei diversi consueti compagni di caccia che accompagnano il Principe nelle sue scorribande agresti.
Magistrale è, infine, la descrizione della moglie di Don Calogero Sedara, donna Bastiana, …“una specie di contadina, bellissima, ma giudicata dal marito stesso, per più d’un verso, impresentabile”, poiché ….“non sa scrivere, non sa leggere, non conosce l’orologio”. E’ presentata, con arguta ironia, come “una bellissima giumenta, voluttuosa e rozza, buona ad andare a letto, e basta”. Risalta che è “anche incapace di voler bene alla figlia”.
 Non va dimenticata, ancora, la caratteristica figura del nobiluomo Chevalley di Monterzuolo, …”rampollo di un di quelle famiglie della piccola nobiltà piemontese che viveva in dignitosa ristrettezza”. Era stato inviato in Sicilia da Vittorio Emanuele II per offrire al Principe la nomina a senatore del Regno sdegnosamente rifiutata dall’interessato. Non va dimenticata, ancora, la caratteristica figura del nobiluomo Chevalley di Monterzuolo, …”rampollo di un di quelle famiglie della piccola nobiltà piemontese che viveva in dignitosa ristrettezza”. Era stato inviato in Sicilia da Vittorio Emanuele II per offrire al Principe la nomina a senatore del Regno sdegnosamente rifiutata dall’interessato.
E che dire di Don Ciccio Tumeo - l’organista della Chiesa Madre che nutre un astio implacabile per il Sindaco Sedara - o di Mariannina, la contadinotta di facili costumi, “bonariamente carnale”, che, all’occasione, si comporta con Don Fabrizio “come un Bendicò in sottanina di seta”. Bendicò, per inciso, era il fedele alano che non molla di un palmo il padrone.
La trama del romanzo, specie nella parte finale, è intessuta da una sequela d’episodi, di attente descrizioni, di precisi riferimenti, di pesanti affermazioni. Essa si sviluppa senza mai divenire barbosa, pur se in qualche parte appare irrimediabilmente prolissa. Le pagine finali, quando il Principe sente coscientemente avvicinarsi il momento del trapasso, sono in gran parte dedicate alla sua ieratica figura (…“Signore, dammi la forza e il coraggio di guardare il mio cuore e il mio corpo senza vergogna”) ed al mesto ma incontrastabile tramonto delle figlie, ormai avviate verso l’indifferibile e inevitabile età attempata.
Il libro, in ultima analisi, ha una fisionomia del tutto particolare, benché sostanzialmente non si discosta dagli schemi narrativi di altre opere letterarie del tempo. Pur avendo a sfondo il già indicato specifico periodo storico, che avrebbe dovuto segnare il definitivo passaggio della Sicilia feudale agli attesi “tempi migliori” (mendacemente annunciati dai fautori del nuovo Regno), non è tuttavia classificabile fra i testi di una autentica corrente letteraria storica, ma può essere annoverato, più opportunamente, nel ricco e vario filone romanzesco - psicologico. La natura dei personaggi e la sostanzialità delle descrizioni si presentano come immersi in un’atmosfera che sta quasi al di fuori del tempo ristretto e dello spazio limitato in cui la vicenda si svolge, mentre il senso generale che s’avverte, andando avanti nella lettura, è quello della irreversibile peribilità d’uomini e cose. Il senso fatalistico domina ovunque, nell’indole pigra ma talvolta dura del Principe, nel suo profondo scetticismo, nel disincantato maturare degli avvenimenti, nell’afa del monumentale palazzo palermitano, nell’atmosfera agreste del protettivo rifugio barocco di Donnafugata. Risalta chiaramente, in buona sostanza, come la nuova situazione della Sicilia, pur evolvendosi verso svolte importanti, non presupponga alcunché di buono per il futuro e non offra alcuna speranza di effettivo miglioramento per il presente.
Anche Garibaldi e i suoi seguaci sono collocati in una particolare luce che non è certo quella dei libri di storia: “garibaldini erano per chi voleva esaltarli e garibaldesi per chi li vituperava”.
I luoghi e il luminoso scenario dei paesaggi inducono, invece, a pensieri più sereni e confortanti e trovano adeguato riscontro nell’attenta descrizione di taluni particolari come, ad esempio, i cespugli di “rose Neyron”, “…odoranti morbosamente come una ballerina dell’Opera”, i sempreverdi arbusti di
“mortella” che, con i loro fiori bianchi, ingentiliscono i siti adiacenti il palazzo, le piante d’agrumi che elargiscono “l’aroma nuziale delle zagare”, la recinzione
di “buganvillea che straripava con cascate come seta epicospale”, i filari di “eucaliptus”, “i più sbilenchi figli di Madre Natura”.
Tutta l’opera è percorsa da una continua allusione alla triste realtà epocale che si rispecchia nella vita della campagna siciliana di allora, magari abbondantemente fertile ma spesso desolata, nelle insalubri e rattoppate borgate soggette ancora ad un regime quasi feudale, nei palazzi sontuosi ma poco curati, come quello di Donnafugata, e persino nel carattere dello stesso protagonista, che, dichiaratamente scettico verso i tempi nuovi, si dimostra consapevole e rassegnato nel prendere atto della fine inesorabile delle vecchie istituzioni e del mondo cui egli stesso appartiene. Quello stesso mondo che lo vede protagonista che, nonostante tutto, lo porta a palesare ancora un accorato rispetto per Re Francesco (“Franceschiello”). Un monarca da avanspettacolo che ai suoi occhi “non valeva molto” e a cui non risparmia mordaci sberleffi come, ad esempio, quando racconta come si lasciasse spesso trasportare dal vezzo di adoperare, con “cordialità plebea”, …“le più fresche volgarità napoletane”, o quando fa cenno al fatto che egli “pazzia” per “i maccarrune e le belle guaglione” o, infine, quando riferisce che, a conclusione dell’ultima udienza concessagli, lo congeda con un “salutamo, Salina, statte bbuono”.
In funzione del fatto che lo schema storico è, in realtà, un finto canovaccio, il libro può quindi considerarsi “autobiografico” solo nella misura in cui si evidenziano quei sintomi del disfacimento nobiliare e della debilitazione personale cui l’autore stesso dovrà poi soggiacere, nel corso dei suoi giorni, con un chiaro accostamento alla sorte del Principe Fabrizio Corbera di Salina.
Il romanzo, per altro verso, acquista un più ampio respiro e valore quando esprime un severo giudizio sul periodo storico cui fa riferimento e denunzia il fallimento del Risorgimento, affermando l’immutabilità dell’esistente realtà e la convinzione che la storia siciliana seguirà la sua strada senza che i nuovi venuti possano influenzarla più di tanto.
Qualcuno è giunto a sostenere che “Il Gattopardo” “ha corroso il mito dell’Unità d’Italia” almeno quanto Silvio Pellico, con le “Le mie Prigioni”, “intaccò l’immagine dell’amministrazione austriaca” nel Lombardo Veneto, nel Friuli e nel Trentino.
Il principe, soprattutto nel colloquio con Chevalley di Monterzuolo (come detto, incaricato di offrirgli la nomina a Senatore del nascente Regno d’Italia), lascia emergere il senso del fatalismo - in lui fortissimo poiché convinto della vanità d’ogni cosa -, il profondo pessimismo, la totale sfiducia in una concreta possibilità di cambiamento per la Sicilia. Egli assiste con distacco al passaggio dal potere borbonico, che ha sempre rispettato, a quello sabaudo che non stima ma che, quale cittadino della rabberciata Italia, accetterà. Non nasconde, però, la sua sofferenza nel costatare che il vecchio mondo al quale appartiene e la vecchia nobiltà che lo circonda, stanno crollando, ineluttabilmente, assieme al regno dei Borboni. Del resto, nulla di diverso ci si poteva attendere come conseguenza del malgoverno di una dinastia inetta e ingorda che si vantava di amministrare i territori di pertinenza all'insegna del motto "festa e forca" !
Il Principe è altrettanto consapevole del fatto che il “diverso” che si affaccia all’orizzonte, non è fatto per le persone come lui, ma per individui “nuovi”, avidi di potere e di rivincita (“il machiavellismo incolto di molti siciliani”); parimenti si rende conto che la nuova classe dirigente (gli aristocratici che si vanno adattando o la borghesia che aspira al potere) non sarà migliore della vecchia e che, nella sostanza, la situazione non cambierà. In definitiva, l’unica cosa certa è che alla monarchia borbonica (“che ha in viso i segni della
morte”) succederà “il Piemontese, il cosiddetto Galantuomo che fa tanto chiasso nella sua piccola capitale fuor di mano”.
Da tali convinzioni derivano la profonda tristezza del Principe e la tendenza a sentire profondamente l’approssimarsi della sua fine, come se fosse sospinto a tali pensieri dal disfacimento ineluttabile di tutte le cose nelle quali ha creduto.
La delusione per il presente e il crollo delle speranze per l’avvenire, danno al protagonista il tono scettico e disincanto di chi, acutamente, intuisce una condizione di crisi e di precarietà. Ecco il motivo per cui tale atteggiamento riporta la mente all’angoscia ed alle inquietudini dei giorni d’oggi, sebbene i personaggi e gli avvenimenti siano narrativamente ambientati nel lontano ’800.
Il libro, sottratto alla dimensione storica, collocandosi, come detto, nel filone del romanzo psicologico, va positivamente valutato, a detta di molti, anche per il frequente ricorso alla metafora cui è affidato il compito di fare risaltare lo stato d’animo del Principe, palesemente sfiduciato e ormai convinto che la Sicilia sembra essere “una centenaria trascinata in carrozzina”.
E’ da dire, ancora, che in talune frasi del Principe l’autore colloca spesso delle ripetizioni che, in modo solo apparentemente disorganico, servono ad avvalorare il suo pensiero e la volontà di rimarcarlo:
- ….”il sonno, ...caro Chevalley, il sonno è ciò che i siciliani più vogliono”;
- ….“il sole, il sole, … è l’autentico sovrano della Sicilia, il sole violento e sfacciato, il sole narcotizzante, il sole che annulla la volontà dei singoli e mantiene ogni cosa in una immobilità servile…”;
- ….”la nostra sensualità è un forte desiderio d’oblio…”,
- .…“la nostra pigrizia, …i nostri sorbetti”,
- ....”questo paese, …questo clima, …questa nostra estate, ... questa violenza, …questa crudeltà”.
Il periodo storico che fa da sfondo al romanzo è, come già accennato, quello del Risorgimento Italiano la cui fase importante ebbe iniziò nel 1815 quando i movimenti nazionali e liberali divennero i maggiori oppositori dello scenario politico determinatosi dopo il Congresso di Vienna.
Secoli di discordie, d’assurde divisioni territoriali, d’anacronistiche dominazioni straniere, si succedettero prima che, nell’idealistico quadro del Risorgimento, si delineasse la possibilità di riacquistare, nel bene e nel male, l’unità della nazione “Italia” sotto la Casa Savoia del Regno Sardo Piemontese.
Anche la Sicilia, Il 21 ottobre, a seguito del plebiscito indetto dai piemontesi, accettò “obtorto collo” l’annessione al costituendo Regno d’Italia, di chiara marca piemontese.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa tratteggia in maniera incisiva l’indecorosa vicenda del plebiscito che quel giorno si svolse anche a Donnafugata, residenza del Principe Fabrizio Corbera di Salina:
-“…dopo che il seggio elettorale venne chiuso, gli scrutatori si posero all’opera ed a notte fatta venne spalancato il balcone centrale del Municipio e don Calogero si rese visibile adornato dalla panciera tricolore e fiancheggiato da due ragazzini con candelabri accesi, che peraltro il vento spense senza indugio. Alla folla, invisibile nelle tenebre, annunziò che a Donnafugata il Plebiscito aveva dato questi risultati:
Iscritti 515; votanti 512; “sì” 512; “no” zero”.
-“...dal fondo oscuro della piazza salirono applausi ed evviva; …nel tuonare dei mortaretti si spedirono messaggi al Re (a quello nuovo) ed al Generale; qualche razzo tricolore si inerpicò dal paese al buio verso il cielo senza stelle; alle otto tutto era finito, e non rimase che l’oscurità come ogni altra sera, come da sempre”.
“Sulla cima di monte Morco, adesso tutto era nitido, sotto la gran luce; la cupezza di quella notte però ristagnava ancora in fondo all’anima di Don Fabrizio. Il suo disagio assumeva forme tanto più penose in quanto più incerte: non era in alcun modo originato dalle grosse questioni delle quali il Plebiscito aveva iniziato la modifica; i grandi interessi del Regno delle Due Sicilie, gl’interessi della propria classe, i suoi vantaggi privati uscivano ammaccati da tutti questi avvenimenti, ma ancora vitali; …il disagio non era di natura politica e doveva avere radici più profonde radicate in una di quelle cagioni che chiamiamo irrazionali perché seppellite sotto cumuli d’ignoranza di noi stessi.
L’Italia (dei Savoia) era nata in quell’accigliata sera anche a Donnafugata; nata proprio lì in quel paese dimenticato, quanto nell’ignavia di Palermo e nelle agitazioni di Napoli.
Viagrande, 1998 A. Lucchese
RIFERIMENTI STORICI sull’annessione della Sicilia.
Sollecitato da Crispi e da altri esponenti politici siciliani, dopo che la rivoluzione promossa da Rosolino Pilo a Palermo era stata soffocata nel sangue il 4 aprile 1860, Garibaldi addivenne ad organizzare una spedizione in Sicilia, nell’ambito di un preciso piano politico, diplomatico e finanziario nascostamente predisposto da Cavour. Ad essa aderirono, secondo le più aggiornate notizie storiche, 1072 uomini e da ciò prese il nome di “spedizione dei mille”. Fra i molti che seguirono Garibaldi (Bixio, Sartori, i fratelli Cairoli, l’ungherese Turr, Ippolito Nievo, Giuseppe La Masa .ecc.) vi fu anche il poeta scrittore Cesare Abba che divenne il cronista dell’impresa.
La notte tra il 5 e 6 maggio il rabberciato “corpo di spedizione” garibaldino salpò da Quarto (Liguria) su due piroscafi, il “Piemonte” ed il “Lombardo”, concessi a nolo dalla “Compagnia di navigazione Rubattino”.
Rifornitisi d’armi, materiali e vettovaglie, in maniera alquanto avventurosa per non dire piratesca, nel porto di Talomone, le due navi, con i “Mille” a bordo, fecero rotta verso la Sicilia ove presero terra, nel pomeriggio dell’11 maggio, nella marina di Marsala. Lo sbarco venne protetto “a vista” da navi da guerra inglesi (“Intrepid” e “Argus”, al comando del Commodoro Marryat) che tennero a debita distanza i vascelli napoletani (il “Tancredi” e il “Capri”) sopraggiunti per cercare di ostacolare le operazioni. Nel corso dell’occupazione dell’abitato, avvenuta senza incontrare alcuna sostanziale resistenza, si evidenziò il fatto che la popolazione, quasi avesse paura, era rimasta “indifferente” e chiusa nelle abitazioni. Contrariamente a quanto previsto, non vi fu, quindi, alcuna “entusiastica accoglienza”. Il 14 maggio, Garibaldi emanò il noto “proclama di Salemi”, attraverso cui, spavaldamente, rese noto di assumere la “Dittatura” dell’Isola in nome di Vittorio Emanuele II, fornendo così la dimostrazione che non era venuto per liberare la Sicilia dai Borboni (che, alla fine, risulteranno addirittura meno dannosi e vessatori dei proconsoli di Casa Savoia) bensì per portare a compimento l’ambìto e studiato piano di “annessione” del Sud alla
monarchia piemontese. Il “dittatore” Garibaldi, avvalendosi delle congrue assegnazioni finanziarie fornitegli (circa 8/milioni, in ducati d’oro e titoli bancari) e delle rilevanti “confische” delle risorse monetarie dei vari dipartimenti siciliani mano a mano occupati, si diede da fare per “corrompere” i più diretti responsabili militari napoletani, fra cui il Gen.le Landi (comandante del settore occidentale della Sicilia) e il Gen.le Lanza, Luogotenente del Re delle Due Sicilie.
 · E’ bene ricordare, per inciso, che Casa Savoia era già stata responsabile, nel 1713, ad opera di Vittorio Amedeo II°, della sottrazione di ingenti somme di denaro in danno della Sicilia, oltre che di un inqualificabile inganno, per avere vanificato l’aspirazione del popolo siciliano a fare dell’Isola un Regno indipendente. Vittorio Amedeo II, infatti, era stato designato, dal trattato di Utrecht, a divenire Re di Sicilia. La Spagna di Filippo V aveva preteso che in detto trattato fosse inclusa la clausola secondo cui “Casa Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o scambiarla con un altro territorio”. Chiaramente ciò non avvenne e Vittorio Amedeo, dopo poco più di un anno dalla solenne incoronazione nella Cattedrale di Palermo, se ne tornò a Torino con la ricca “cassa del regno di Sicilia” e, senza por tempo in mezzo, approfittò dell’occasione di scambiare l’Isola, per puri motivi di opportunità dinastica, con la Sardegna. La Sicilia attende ancora che i Savoia restituiscano il maltolto e la rifondano per i danni arrecatole. · E’ bene ricordare, per inciso, che Casa Savoia era già stata responsabile, nel 1713, ad opera di Vittorio Amedeo II°, della sottrazione di ingenti somme di denaro in danno della Sicilia, oltre che di un inqualificabile inganno, per avere vanificato l’aspirazione del popolo siciliano a fare dell’Isola un Regno indipendente. Vittorio Amedeo II, infatti, era stato designato, dal trattato di Utrecht, a divenire Re di Sicilia. La Spagna di Filippo V aveva preteso che in detto trattato fosse inclusa la clausola secondo cui “Casa Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o scambiarla con un altro territorio”. Chiaramente ciò non avvenne e Vittorio Amedeo, dopo poco più di un anno dalla solenne incoronazione nella Cattedrale di Palermo, se ne tornò a Torino con la ricca “cassa del regno di Sicilia” e, senza por tempo in mezzo, approfittò dell’occasione di scambiare l’Isola, per puri motivi di opportunità dinastica, con la Sardegna. La Sicilia attende ancora che i Savoia restituiscano il maltolto e la rifondano per i danni arrecatole.
La
Sicilia attende ancora che i Savoia restituiscano il maltolto e la
rifondano per i danni arrecatole.
Il primo scontro con le truppe borboniche avvenne a Calatafimi ove il modesto contingente garibaldino, cui s’era aggregato un qualche migliaio di raccogliticci “Picciotti” (in aggiunta ai “fuorilegge” e alle “bande mercenarie” arruolati da alcuni potenti signorotti locali quali i Florio, i Favara, i Triolo, ecc.), l’ebbe vinta sul ben più forte e numeroso Corpo militare borbonico (pur ritenuto “uno dei migliori e più addestrati eserciti d’Europa”), comandato dal corrotto Gen.le Landi. Quest’ultimo, come successivamente ebbe a confessare, venne lautamente compensato da Garibaldi (16/mila ducati in cartelle del Banco di Napoli) per fare si che il grosso delle truppe napoletane fosse tenuto lontano dal campo di battaglia, di modo che non potesse intervenire prontamente in quella che poi passerà alla storia, molto pomposamente, come “battaglia di Calatafimi”. Il peso dello scontro fu sostenuto, in definitiva, solo da due compagnie di “cacciatori” borbonici. La corruzione di generali, ammiragli, alti funzionari e addirittura di ministri di Re Francesco II, sembra sia stato il più importante fra i fattori che consentirono la pressoché indisturbata marcia di Garibaldi verso Palermo. Pochi giorni dopo le “camicie rosse” entrarono in quella Città, peraltro sempre ben protette dalle navi da guerra inglesi (cui si era aggiunta la “Amsterdam” con a bordo parecchie centinaia di soldati inglesi) minacciosamente posizionate in rada unitamente a due fregate americane, la “Washington” e la “Franklin”. Si spiega, così, il perché il grosso della flotta napoletana fosse rimasto inattiva nei porti di Gaeta e di Napoli. Il Luogotenente del Re, generale Lanza, fece solo finta di difendere la capitale della Sicilia dalle variegate e raffazzonate soldatesche garibaldine. Piuttosto che starsene a poltrire nelle fastose stanze del Palazzo Reale, avrebbe potuto facilmente inchiodarle presso Ficuzza, Marineo e Misilmeri, lungo l’unica strada che allora conduceva a Palermo. In un primo momento lo stesso Garibaldi aveva ritenuto rischiosa la marcia verso la Città e intendeva rifugiarsi fra le montagne per attendere tempi migliori.
Anche Crispi, come scrive Carlo Pecorini Manzoni in un libro che narra le avventure dei reparti comandati del patriota ungherese Turr, era di pari avviso.
E’ bene sapere, pur senza scadere in prolissi particolari, che il Luogotenente Lanza, dopo essersi appropriato di seicentomila ducati del Banco di Sicilia, aveva combinato le cose in modo da “facilitare” l’ingresso di Garibaldi (27 maggio) al quale s’affrettò a chiedere prestamente un armistizio, preventivato e immediatamente accordato. Tale atto d’ignominiosa resa comportò il fatto che poche migliaia di “camicie rosse” riuscissero a rendere inoffensivi ben 24/mila soldati borbonici, proprio quando le brigate autonome dei generali Colonna e Von Mechel, confluendo dalla periferia verso il centro, avevano ripreso il controllo della situazione e procedevano verso il Palazzo Reale facendo correre il rischio ai piemontesi di essere scacciati dalla Città.
A nulla valse il conseguente e tardivo intervento del Re che, deluso e amareggiato, aveva ordinato di arrestare e processare il generale Lanza.
Solo la piazzaforte di Milazzo, nelle settimane successive, fu validamente e coraggiosamente difesa, più per iniziativa e capacita personale del Col. Ferdinando Beneventano del Bosco (discendente di una nobile famiglia siracusana) che in virtù di preordinati piani strategici, del resto inesistenti vista la codardia e la corruzione che imperversavano negli alti comandi borbonici. La resistenza si protrasse sino al 23 luglio e segnò momenti di dura lotta e d’inusitato valore da parte dei difensori. L’eco dell’epica lotta si diffuse in vicine e lontane contrade, giungendo anche a Corte, in quel di Napoli ove, invece, prevaleva ormai il peggiore disfattismo. Il 17 agosto, rientrato a Napoli, Ferdinando Beneventano del Bosco ricevette personalmente dal Re il decreto di nomina a Generale di Brigata per i suoi riconosciuti meriti. peggiore disfattismo. Il 17 agosto, rientrato a Napoli, Ferdinando Beneventano del Bosco ricevette personalmente dal Re il decreto di nomina a Generale di Brigata per i suoi riconosciuti meriti.
Anche lo scrittore garibaldino Cesare Abba, ritenne giusto e doveroso esaltarne la figura e scrisse: “…la fortuna sfuggì di mano a questo siciliano giovane, ardito e ricco d’ingegno”.
Con la presa di Milazzo fu sostanzialmente completata l’occupazione della Sicilia, mentre i resti dell’esercito borbonico s’erano ritirati oltre lo Stretto.
L’annessione al "Regno Sabaudo" (21 ottobre 1860) e poi al "Regno d'Italia" (17 marzo 1861), non servì a colmare, in ogni caso, l’esistente divario strutturale ed economico fra nord e sud. Esso, per molti versi, s’accentuò, sia per l'avvento dell’assillante burocrazia “centralista” di stampo piemontese che per le carenze strutturali dei servizi oltre che per l’inadeguata rete di comunicazioni, addirittura inesistente in molte zone del più profondo meridione. A fronte dell’incancrenirsi della crisi, a Torino non si ritenne doveroso o impellente aiutare i nuovi “fratelli italiani” nel risolvere gli atavici problemi.
Principalmente per effetto della mancanza di sufficienti fonti di lavoro e di qualsivoglia forma d’assistenza, l'acuirsi delle difficoltà costrinse centinaia di migliaia di siciliani ad abbandonare la propria terra per cercare all'estero una pur minima fonte di sostentamento. I “nuovi padroni savoiardi”, pervasi da un’ipocrita mentalità sciovinista, avvezzi ai più deprecabili opportunismi, fautori di deludenti guerre coloniali, nulla ritennero di dover fare per contenere l’emorragia dell'esodo. E non va dimenticata, in aggiunta, l’inaudita quanto deprecata vessazione della "coscrizione obbligatoria di cinque anni" che aveva innescato violenti tumulti, dai piemontesi domati con spietatezza di stampo colonialista.
Nel momento della confluenza delle tanto diverse realtà regionali in un unico Stato, talvolta aggregate con sistemi poco ortodossi, quando non cruenti, si fece ben poco, per non dire nulla, ai fini di creare una comunione d’intenti e di valori fra le diverse comunità.
Quale esponente politico di primo piano del nuovo Stato, fu D’Azeglio il primo ad esprimere, in merito, un chiaro pensiero affermando che la pura e semplice attuazione dell’unità geografica della penisola italiana non poteva prescindere dalla necessità di “fare gli italiani”.
Oltre che adoperarsi per formare una “coscienza nazionale”, sarebbe occorso promuovere tutte quelle iniziative politiche e legislative atte a creare la struttura di uno Stato moderno ed efficiente attraverso cui realizzare un paritetico inserimento dell’Italia fra le altre Nazioni.
Un bel sogno che, almeno per quanto riguarda la “coscienza nazionale”, ancora oggi stenta a realizzarsi.
In campo economico, peraltro, alle attività produttive, all’industria, al commercio e alle infrastrutture del Nord continuarono ad essere assegnati sempre più copiosi incentivi finanziari mentre, di riflesso, non si pose alcuna cura per evitare l’incancrenirsi del deleterio “problema meridionale”.
Con buona pace di coloro che avevano creduto e continuano a credere in una Italia “unita e solidale” !
A. Lucchese
|

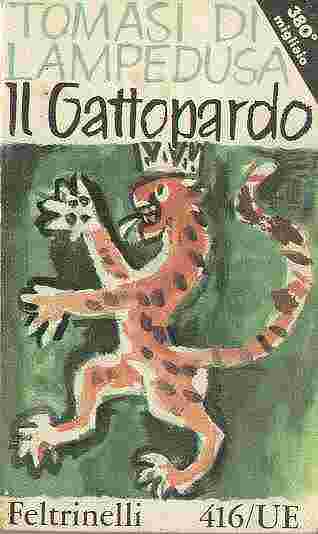 In uno alle tematiche delle varie epoche, ai testi allegorici, al documentarismo storico-sociale, la narrativa italiana del ‘900 ha dato particolare rilevanza, più o meno obiettivamente e realisticamente, alle problematiche socio ambientali delle regioni del Sud e particolarmente della Sicilia. Ciò perché il Sud ha rappresentato da sempre, e forse lo rappresenta tuttora, un mondo a se. Portatore d’antichissima storia e cultura, di radicate tradizioni, ricchissimo d’impareggiabili paesaggi e d’insigni monumenti, è stato nei secoli oppresso e sfruttato, trascurato e dimenticato, talvolta con la connivenza di ben noti esponenti della classe nobiliare e politica, oltre che di una parte della gerarchia ecclesiastica. Le inadeguate iniziative adottate nel corso del pur deprecato “ventennio”, tendenti ad attutire le conseguenze delle ben note colpevolezze di matrice borbonica e, ancor più, dei governi succedutisi dopo il l’unificazione della penisola sotto Casa Savoia (1870), furono solo dei palliativi e non rappresentarono affatto una svolta. Il “problema meridionale”, anche nell’ambito del nuovo quadro istituzionale e politico del secondo dopoguerra (1946), si ripropose in tutta la sua gravità. In Sicilia, in particolare, ci si trovò di fronte al riaffiorare di sussulti separatisti mentre ci si dovette rendere conto che le già scarse fonti di ricchezza s’erano vieppiù concentrate nelle mani di una ristretta cerchia di operatori che badavano, in quanto privi di interessi sociali, solo ai propri profitti. In molti casi, addirittura, ci si trovò al cospetto di speculatori arricchitisi con raggiri, con sistemi da “borsa nera” e con l’usura. Il “latifondo”, per altro verso, era divenuto la palla al piede delle moribonde classi nobili e patriarcali. Una nuova e massiccia emigrazione fu la conseguenza di tale stato di cose ed ebbe l’effetto di depauperare la forza lavorativa che faceva capo alle classi medio basse. In tutta la sua ampiezza e gravità emerse una situazione precaria ed esplosiva che, in relazione ai fattori storico politici da cui traeva origine l’evidente arretratezza del Meridione e a fronte della tangibile miseria che affliggeva la gran massa della popolazione, stava determinando un clima di violenza e di scontri sociali in cui il “conservatorismo” recitava la parte del mandante e la “sinistra” tentava di stare al passo con finalità financo rivoluzionarie. La tanto strombazzata solidarietà nazionale, anche questa volta, perse l’occasione di agire in maniera risolutiva, malgrado fosse stata evidenziata, da più parti, la necessità di intervenire al più presto con speciali e concreti provvedimenti sociali e strutturali.
In uno alle tematiche delle varie epoche, ai testi allegorici, al documentarismo storico-sociale, la narrativa italiana del ‘900 ha dato particolare rilevanza, più o meno obiettivamente e realisticamente, alle problematiche socio ambientali delle regioni del Sud e particolarmente della Sicilia. Ciò perché il Sud ha rappresentato da sempre, e forse lo rappresenta tuttora, un mondo a se. Portatore d’antichissima storia e cultura, di radicate tradizioni, ricchissimo d’impareggiabili paesaggi e d’insigni monumenti, è stato nei secoli oppresso e sfruttato, trascurato e dimenticato, talvolta con la connivenza di ben noti esponenti della classe nobiliare e politica, oltre che di una parte della gerarchia ecclesiastica. Le inadeguate iniziative adottate nel corso del pur deprecato “ventennio”, tendenti ad attutire le conseguenze delle ben note colpevolezze di matrice borbonica e, ancor più, dei governi succedutisi dopo il l’unificazione della penisola sotto Casa Savoia (1870), furono solo dei palliativi e non rappresentarono affatto una svolta. Il “problema meridionale”, anche nell’ambito del nuovo quadro istituzionale e politico del secondo dopoguerra (1946), si ripropose in tutta la sua gravità. In Sicilia, in particolare, ci si trovò di fronte al riaffiorare di sussulti separatisti mentre ci si dovette rendere conto che le già scarse fonti di ricchezza s’erano vieppiù concentrate nelle mani di una ristretta cerchia di operatori che badavano, in quanto privi di interessi sociali, solo ai propri profitti. In molti casi, addirittura, ci si trovò al cospetto di speculatori arricchitisi con raggiri, con sistemi da “borsa nera” e con l’usura. Il “latifondo”, per altro verso, era divenuto la palla al piede delle moribonde classi nobili e patriarcali. Una nuova e massiccia emigrazione fu la conseguenza di tale stato di cose ed ebbe l’effetto di depauperare la forza lavorativa che faceva capo alle classi medio basse. In tutta la sua ampiezza e gravità emerse una situazione precaria ed esplosiva che, in relazione ai fattori storico politici da cui traeva origine l’evidente arretratezza del Meridione e a fronte della tangibile miseria che affliggeva la gran massa della popolazione, stava determinando un clima di violenza e di scontri sociali in cui il “conservatorismo” recitava la parte del mandante e la “sinistra” tentava di stare al passo con finalità financo rivoluzionarie. La tanto strombazzata solidarietà nazionale, anche questa volta, perse l’occasione di agire in maniera risolutiva, malgrado fosse stata evidenziata, da più parti, la necessità di intervenire al più presto con speciali e concreti provvedimenti sociali e strutturali. 

 Non va dimenticata, ancora, la caratteristica figura del nobiluomo Chevalley di Monterzuolo, …”rampollo di un di quelle famiglie della piccola nobiltà piemontese che viveva in dignitosa ristrettezza”. Era stato inviato in Sicilia da Vittorio Emanuele II per offrire al Principe la nomina a senatore del Regno sdegnosamente rifiutata dall’interessato.
Non va dimenticata, ancora, la caratteristica figura del nobiluomo Chevalley di Monterzuolo, …”rampollo di un di quelle famiglie della piccola nobiltà piemontese che viveva in dignitosa ristrettezza”. Era stato inviato in Sicilia da Vittorio Emanuele II per offrire al Principe la nomina a senatore del Regno sdegnosamente rifiutata dall’interessato.  · E’ bene ricordare, per inciso, che Casa Savoia era già stata responsabile, nel 1713, ad opera di Vittorio Amedeo II°, della sottrazione di ingenti somme di denaro in danno della Sicilia, oltre che di un inqualificabile inganno, per avere vanificato l’aspirazione del popolo siciliano a fare dell’Isola un Regno indipendente. Vittorio Amedeo II, infatti, era stato designato, dal trattato di Utrecht, a divenire Re di Sicilia. La Spagna di Filippo V aveva preteso che in detto trattato fosse inclusa la clausola secondo cui “Casa Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o scambiarla con un altro territorio”. Chiaramente ciò non avvenne e Vittorio Amedeo, dopo poco più di un anno dalla solenne incoronazione nella Cattedrale di Palermo, se ne tornò a Torino con la ricca “cassa del regno di Sicilia” e, senza por tempo in mezzo, approfittò dell’occasione di scambiare l’Isola, per puri motivi di opportunità dinastica, con la Sardegna. La Sicilia attende ancora che i Savoia restituiscano il maltolto e la rifondano per i danni arrecatole.
· E’ bene ricordare, per inciso, che Casa Savoia era già stata responsabile, nel 1713, ad opera di Vittorio Amedeo II°, della sottrazione di ingenti somme di denaro in danno della Sicilia, oltre che di un inqualificabile inganno, per avere vanificato l’aspirazione del popolo siciliano a fare dell’Isola un Regno indipendente. Vittorio Amedeo II, infatti, era stato designato, dal trattato di Utrecht, a divenire Re di Sicilia. La Spagna di Filippo V aveva preteso che in detto trattato fosse inclusa la clausola secondo cui “Casa Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o scambiarla con un altro territorio”. Chiaramente ciò non avvenne e Vittorio Amedeo, dopo poco più di un anno dalla solenne incoronazione nella Cattedrale di Palermo, se ne tornò a Torino con la ricca “cassa del regno di Sicilia” e, senza por tempo in mezzo, approfittò dell’occasione di scambiare l’Isola, per puri motivi di opportunità dinastica, con la Sardegna. La Sicilia attende ancora che i Savoia restituiscano il maltolto e la rifondano per i danni arrecatole. peggiore disfattismo. Il 17 agosto, rientrato a Napoli, Ferdinando Beneventano del Bosco ricevette personalmente dal Re il decreto di nomina a Generale di Brigata per i suoi riconosciuti meriti.
peggiore disfattismo. Il 17 agosto, rientrato a Napoli, Ferdinando Beneventano del Bosco ricevette personalmente dal Re il decreto di nomina a Generale di Brigata per i suoi riconosciuti meriti.